Il «lungo Sessantotto». La definizione ha una significatività storiografica specificamente italiana. Infatti, in Italia, diversamente da altri paesi, il Sessantotto fu un fenomeno di lunga durata preceduto dall’inquieta età degli anni Cinquanta (segnata nel mondo giovanile dalle mode esistenzialiste e dalle accensioni creative della cosiddetta beat generation), e destinato a prolungarsi in avanti nel tempo, per un decennio ed oltre, riattivandosi in forme esplosive nel 1977, per poi esaurirsi lentamente, quasi per stanchezza dei suoi protagonisti e soprattutto per l’imbarbarimento progressivo delle sue istanze originarie nella tragica stagione del terrorismo, indicata altrimenti, e certo a ragione, come la «notte della Repubblica».
Può ben dirsi che il Sessantotto italiano ebbe termine definitivamente come fenomeno riconoscibile (comprese le sue degenerazioni) soltanto nei primi anni Ottanta, spegnendosi infatti in quella fase sociale di cosiddetto «riflusso» (rispetto alle utopiche tensioni rivoluzionarie sessantottine per “cambiare il mondo”) segnata dal ritorno alle suggestioni ben più modeste e realistiche del “privato”, nonché dall’ingresso passivo delle nuove leve giovanili nel circuito maturo di una società ormai egemonizzata dalle sirene del consumismo. Dagli anni Ottanta in poi, sarebbe diventata dominante tra i giovani la tendenza ad una conformistica accettazione dell’esistente (quasi una ventata di consapevole disincanto e di saggio adattamento al “possibile” in alternativa ai padri che avevano provocatoriamente gridato nelle piazze «vogliamo l’impossibile!»), con un adeguamento più o meno consapevole – talvolta dolente, altre volte fiducioso e festoso –, alle ragioni oggettive di un capitalismo vittorioso che sembrava distribuire benessere e premiare le attese di affermazione sociale degli elementi più dinamici e “rampanti”. In un certo senso, il Sessantotto, come meglio vedremo più avanti, si sarebbe convertito in un anti-Sessantotto. E la cosa più vistosa in tutto questo sarebbe stata l’ascesa a numerose posizioni di potere – nella politica e negli establishment dei partiti, nella pubblica amministrazione, nel mondo esclusivo dell’alta cultura ufficiale, delle grandi agenzie della comunicazione e dell’informazione, della pubblicità e dei mass-media, dell’economia e degli affari e, largamente, delle stesse università – di gran parte dei sessantottini che pochi anni prima erano emersi sulla scena pubblica della storia inalberando la bandiera della lotta al cosiddetto “sistema” cioè proprio al sistema capitalistico indicato come la forma più oppressiva e perversa di potere.
Vedendo adesso le cose alla distanza, si potrebbe ben dire che in definitiva il Sessantotto congiurò contro se stesso? Che il suo esito estremo – dopo un lungo itinerario passato attraverso la tragedia del terrorismo (avviata dall’improprio e anomalo revival del 1977) – fu il tradimento delle sue finalità originarie? Che la sua sorte fu quella, assai paradossale, di convertire lo slancio rivoluzionario del suo anno aureo e fatale, appunto il 1968, in una controrivoluzione? Che è tristemente normale che le grandi tensioni utopiche, proprio in quanto e perché utopiche, alla fine si risolvano in una disincantante “normalizzazione”? In altri termini, è corretto dare al Sessantotto, nella sua vicenda tipicamente italiana di «lungo Sessantotto», la registrazione storiografica di un lungo fallimento generazionale?
Se si rispondesse affermativamente a siffatte domande (e ad altre analoghe sempre più correnti, oltre che nella storiografia, nella più vasta pubblicistica sull’argomento) si incorrerebbe di volta in volta in affermazioni dotate di parziale verità, ma nell’insieme errate. Perché è invece un vero storico di cui è stata soprattutto la sociologia a verificare la fondatezza che dopo il Sessantotto l’Italia non sarebbe più stata la stessa di prima. La vecchia Italia di “campagna” delle parrocchie e dei campanili che aveva il suo caposaldo e la sua ecclesìa politica soprattutto nella grande e dominante Democrazia cristiana, così come quella urbana pervenuta da pochi anni (con il cosiddetto «miracolo economico») a mature connotazioni di società industriale e largamente orientata nelle sue tensioni e nei suoi valori dal grande Partito comunista costruito da Togliatti, parve riceverne le stigmate e subirne nel contempo decisive e irreversibili trasformazioni molto simili a quelle in genere prodotte dalle grandi rivoluzioni sociali della storia.
Protagonisti i giovani, quelli della gioventù studiosa delle università e soprattutto, tra loro, i figli dei lavoratori, degli operai e dei contadini, forze emergenti di ceti sociali che per secoli non avevano avuto accesso agli studi superiori e che varcavano adesso quella soglia forzando antiche barriere di classe, tramite i canali approntati dalle stesse istanze modernizzatrici del cosiddetto neocapitalismo, che da una parte erano all’origine delle nuove oppressioni della società urbano-industriale e, dall’altra, avendo bisogno di un’inusitata dotazione di quadri tecnici e professionali, stava incentivando ad ampio raggio la scolarizzazione fino a propiziare il passaggio dalla vecchia università d’élite dominata dai “baroni del sapere” ad un’università di massa nella quale sarebbero stati sempre più protagonisti, in conflitto con i baroni, i professorini incaricati, i ricercatori precari, gli assistenti. Protagonisti, pertanto, quasi “necessari”, proprio gli studenti (fin dalle lotte avviate dalle organizzazioni studentesche nel 1964 e poi negli anni successivi, in anticipo sugli analoghi movimenti in altre parti del mondo dall’America all’Europa, fino all’incentivazione che sarebbe venuta dalla lezione del maggio francese). E protagonisti, insieme agli studenti, i professorini e gli assistenti. E protagoniste, finalmente, e per la prima volta nella storia, le donne, molte donne, che con l’accesso agli studi superiori scoprivano e “reinventavano” il femminismo, sottraendolo ad una tradizione storica che in Italia era stata fondamentalmente elitaria, borghese ed alto-borghese.
Tutto sembrò messo in frenetica discussione. Tutto subì pubblici processi e radicali revisioni. Tutto fu invaso da un’ondata di corrosioni e di delegittimazioni, di critiche travolgenti al presente (quel detestato “sistema”!) e al passato (le ipocrite certezze e sicurezze registrate dai repertori di idee e prescrizioni delle agenzie dominanti del consenso, ovvero dell’oppressivo potere di istituzioni storiche come la Chiesa-Vaticano, di forme organizzative del pubblico come la burocrazia ancora segnata da un’insuperata continuità generazionale e ideologica con quella fascista e come gli stessi partiti dediti a gestire una democrazia dai caratteri filistei che sostanzialmente tradiva nella prassi quotidiana le fonti di una recente legittimazione storica che veniva dall’antifascismo e dalla Resistenza).
Tutto quindi in discussione a sinistra, dove l’attacco al “sistema” prese la strada di un attacco mosso da una sinistra giovanile, che si era formata nel Pci, alla dirigenza dello stesso Pci accusato di stalinismo e di ubbidienza cieca all’Unione Sovietica; un attacco concretizzatosi nella formazione di movimenti “al di là del Pci” e antisovietici che guardavano con ammirazione e con speranza alle suggestioni rivoluzionarie della Cina della Rivoluzione culturale e di Fidel Castro, del castrismo e di Che Guevara.
Ma tutto, o molto, in discussione anche a destra, dove un’altra gioventù a suo modo intenzionalmente “rivoluzionaria” rimproverava al partito neofascista ufficiale (il Movimento sociale italiano di Arturo Michelini e di Augusto De Marsanich) di essersi adattato a un ruolo di supporto alla Democrazia cristiana, un ruolo filoamericano e nella sostanza “antinazionale”, con un ceto dirigente incialtronito dai compromessi e dalla rinunzia ad un autentico fascismo. Ovviamente, Sinistra e Destra, antifascismo e fascismo avrebbero animato gli scontri tra le due gioventù in rotta con le rispettive tradizioni, l’una contro l’altra, nelle università, nelle scuole, infine nelle piazze.
C’erano, quindi, due aree squilibrate di movimenti giovanili, squilibrate perché quelli di sinistra nati alle spalle del Pci e del Psi, e talvolta dentro gli stessi Pci e Psi, erano certamente molto più numerosi e tenevano il campo nelle università, tra Potere operaio, Manifesto, Servire il popolo e Cristiani per il socialismo, maoisti, trotzskisti e guevaristi, poi Lotta continua, ecc. È noto che tra la sinistra e la destra giovanili presto si sarebbero inserite delle oscure forze eversive manipolate dai cosiddetti servizi segreti deviati, forze interessate a destabilizzare l’Italia per ordire nelle sedi senza volto dei poteri occulti (paralleli, e spesso sovrapposti, a quelli ufficiali della Repubblica) le trame di eventuali colpi di Stato, alla maniera dei colonnelli greci, da opporre a una temuta conquista del governo da parte dei comunisti e delle forze anticapitaliste e antiatlantiche: un timore, molto intenso soprattutto nei ceti medi, che aveva le sue fonti immediate nei dati elettorali che evidenziavano una costante avanzata del Pci e nei movimenti di massa che parevano sospingere il paese verso un’imminente rivoluzione.
Ma che questo stesse accadendo i giovani dei movimenti sessantottini non lo sapevano e, ancora, non potevano saperlo. Loro erano piuttosto impegnati nello sforzo di mettere in moto una “rivoluzione culturale”, un cambiamento della mentalità collettiva, una lievitazione dei valori dell’autenticità, della “naturalezza”, della spontaneità del vivere e del testimoniare la vita contro l’autoritarismo, la perfidia, la mediocrità borghese, l’ipocrisia, il bigottismo e il “tradimento” di padri e maestri, di burocrati e di baroni.
Loro, entrando nella nebulosa internazionale di una specie di “globalizzazione della gioventù” sospinta dai campus studenteschi dell’America di Berkeley, di Martin Luther King e di Malcom X all’Europa del maggio parigino, esprimevano nuovi stili e nuovi linguaggi potenziando gli umori recenti della beat generation; esibivano rumorosamente una nuova cultura nutrita dalla Scuola di Francoforte; recitavano collettivamente quella nuova cultura e ne riconoscevano i ritmi incalzanti nella musica scandalosamente dinamica, “eversiva” e insieme gioiosa del rock’n’roll, ne espandevano il senso liberatorio e di inedita umanizzazione nella rivendicazione esibita della libertà sessuale, con i miti politici (il Che, Ho Chi Min, Giap, ma anche Mao Zedong e tanti altri) che si coniugavano con i miti esistenziali (Marilyn Monroe, Bill Haley, Elvis Presley, Joan Baez, Bob Dylan, poi I Beatles e tanti altri, tra i quali, in Italia, soprattutto Luigi Tenco e Francesco Guccini). E, se erano cattolici, la loro fede richiedeva il rinnovamento e l’ardore cristiano del pontificato di papa Giovanni XXIII (contro il politicantismo “medioevale” e clericale del pontificato di Pio XII), insieme alle ariose aperture alla modernità del Concilio Vaticano II, con il corredo del cristianesimo sociale e del cristianesimo anti-imperialistico della teologia della liberazione.
Di quanto di torbido e di strumentale si stava invece svolgendo nelle loro stesse retrovie oltre che, soprattutto, negli spazi oscuri del potere contro il quale si erano mobilitati, si sarebbero accorti di colpo soltanto dopo, il 12 dicembre 1969, con la bomba esplosa a Milano nella sede della Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana: sedici morti innocenti. Ma, così, come è stato ben scritto, anche i sessantottini “perdettero l’innocenza”.
Il «lungo Sessantotto», già all’indomani della strage di piazza Fontana, si sarebbe diviso in due: da una parte il fragoroso movimentismo avrebbe cominciato il suo lento e inesorabile declino verso la rassegnazione e verso un dolente silenzio intriso di pentimento (quasi a riconoscersi responsabile di eccessi degenerati in un’imprevista e incalcolabile violenza); dall’altra, con la speranza di accendere una rivoluzione politica e sociale al di là degli originari propositi di “rivoluzione culturale”, alcuni suoi esponenti sarebbero entrati nei cunicoli e nei circuiti sempre più oscuri e insalubri di un’avventura disperata che pretendeva di imporre l’utopia di un “mondo da rifare” al movimento operaio che invece, per la verità, pur essendo molto combattivo sul terreno delle lotte sindacali per la giustizia sociale e per i diritti democratici, mostrava piuttosto anche in Italia – come del resto aveva già ben rilevato Max Horkheimer – una preminente tendenza al riformismo nell’ambito del “sistema”. Se da una parte il pentimento si sarebbe involuto nelle abiure, dall’altra, l’insistenza sulla strategia della “rivoluzione” avrebbe prodotto nuovi drammatici scontri tra Sinistra e Destra, nuove strumentalizzazioni da parte delle forze interessate a destabilizzare la società italiana e, come sappiamo, la vicenda dei cosiddetti «anni di piombo», con la tragedia del terrorismo.
Proprio nell’area della degenerazione del movimento sessantottino – in una disperata ricerca della “rivoluzione” a sinistra o della cosiddetta “rivolta nazionale” a destra – si sarebbe sviluppato, con una lunga vicenda di sangue, il dramma, quasi al limite tra un esasperato conflitto sociale e una potenziale nuova guerra civile tra italiani, ben descritto nel film di Amedeo Ricucci, dal titolo sintetico ed agghiacciante, Morire di politica.
Esso indica, paradossalmente, anche gli stati d’animo e gli orientamenti di quanti all’opposto, non volendo affatto «morire di politica», se sessantottini avrebbero ripudiato il sessantottismo e se estranei alla cultura e ai movimenti del Sessantotto avrebbero trasformato quella loro originaria estraneità in un convinto ed integrale rifiuto delle ideologie e degli ideologismi, fino a quel morbido disincanto e a quell’opportunistico adeguamento degli anni Ottanta al “mondo così com’è” al quale ho già accennato.
È quest’ultimo l’orientamento che sembra essersi potenziato negli anni e che oggi ritengo di potere rilevare come assai diffuso e radicato nella generazione del XXI secolo. Si tratta di un orientamento, o meglio, di un processo di depoliticizzazione (e quindi anche, in nuce, di destoricizzazione) che, come ho spiegato in alcuni miei precedenti libri, non si deve tanto al fatto che il lungo Sessantotto italiano sia andato in crisi scindendosi tra l’area dell’abiura e l’area dell’avventura disperata; ma si deve soprattutto a un fenomeno epocale e mondiale che negli anni Settanta ha cominciato a cambiare radicalmente le carte sul tavolo della storia: una rivoluzione dagli effetti non minori della prima rivoluzione industriale (una nuova rivoluzione postindustriale cominciata appunto negli anni Settanta), che era già nel sottofondo del Sessantotto senza che i sessantottini riuscissero ancora a coglierne la sconvolgente intensità “strutturale”; in breve, la rivoluzione che amo definire elettronico-informatica, quella che è all’origine della fenomenologia sociale ed antropologica del cosiddetto “postmoderno” e dei radicali processi di cambiamento attualmente giunti a maturazione nel nuovo secolo al di là delle forme e dei valori della vecchia società industriale nata nell’Ottocento. Sta di fatto che il crollo delle ideologie e degli ideologismi e la destoricizzazione della cultura (la cultura del Sessantotto era stata, invece, una cultura che, per e dentro le ideologie, rappresentava il culmine utopico della valorizzazione romantica della storia, fino a promuovere la stessa utopia al rango di storicità assoluta!) sono processi che marciano insieme, indissociabili. E sta di fatto che nessuno dei giovani di oggi sarebbe benché minimamente disposto a «morire di politica» e neppure, certamente, a «morire di storia».
D’altra parte, chi come me, essendo uno storico, in virtù del suo ufficio civile, ha l’onere di tutelare la memoria critica degli eventi, adesso, ripensando al Sessantotto aureo e fragoroso dell’anno 1968 e al «lungo Sessantotto» degenerato negli anni della violenza e del terrore, non ha certo il compito di “processarli” per addivenire a un qualsiasi giudizio di assoluzione o di condanna. Semmai, ha il compito di suggerirne un’interpretazione il più possibile convincente tentando di cogliere, di quei complessi eventi, sia i loro rapporti di continuità con il passato, sia i fattori di cambiamento e di rottura con il passato che, sempre da quei complessi eventi, si sono proiettati sulle vicende storiche di fine secolo fino a raggiungere il nostro presente. Il che mi sembra di avere già fatto, almeno parzialmente, con la prima parte delle mie riflessioni.
Ma adesso, affrontando una seconda parte, la parte conclusiva, mi sembra persino doveroso proporre un’interpretazione della vicenda del Sessantotto che risulti, per quanto purtroppo più generale e generica, più unitaria e “stringente”. Si tratta, in breve, di inquadrare il complessivo movimento sessantottino nella dialettica giovani-anziani della storia del Novecento.
Per farlo, necessariamente con molto schematismo, mi è utile ritornare al titolo del film appena citato. Quel titolo, Morire di politica, è una frase un po’ ambigua perché potrebbe contenere una valutazione politica positiva della politica, suggerendo che è emozionante e civile immolarsi per una causa politica (e, pertanto, esaltando la politica stessa come valore) oppure, di contro, potrebbe avere una significazione particolarmente negativa: come dire “si muore a causa della politica”, perché la politica (con il suo portato di ideologismi) costituisce un’esperienza pericolosa, fino agli estremi di un vero e proprio pericolo mortale.
In realtà, le vicende del Sessantotto (soprattutto quelle del «lungo Sessantotto», per quanto siano state disperate e spesso violente) mi sembrano più funzionali ad un’altra lettura della frase, una lettura insieme più semplice e dalle valenze esistenziali pienamente conformi agli ideali della generazione sessantottina sia di sinistra che di destra: si può morire di politica se e quando la politica è enfasi dell’impegno per testimoniare una passione che si nutre nel pensiero come una passione civile (un vivere non per sé, ma per gli altri); così, come è possibile morire di amore, si può morire di ideali, quali che siano questi ideali, sempre che siano soggettivamente avvertiti come ideali degni di una dedizione completa ed assoluta. Altra cosa è verificare se si tratta di ideali oggettivamente davvero degni di meritare il sacrificio della vita e, al limite, se valga la pena sacrificarsi per gli ideali, quali che siano. Ma questo non è deciso e verificato dai sentimenti degli individui; è, invece, deciso e verificato dal corso concreto della storia. E i sessantottini, tutti (a parte gli immancabili opportunisti di ogni tempo), a qualsiasi parte politica appartenessero, ciascuno ritenendo già scontata in partenza a suo favore la verifica storica come accade di norma ai giovani, non coltivavano dubbi circa il valore degli ideali che li sospingevano alla lotta e, se necessario, al sacrificio. La loro visione “eroica” e sacrificale dell’impegno politico potrebbe rappresentarsi come l’espressione estrema di una tradizione romantica della gioventù riprodottasi nella storia del Novecento nel passaggio da una generazione ad un’altra. Non a caso, si sarebbe poi esaurita e spenta, come ho già rilevato, con l’affermazione del “postmoderno” e con i crescenti sviluppi della rivoluzione elettronico informatica nell’ultimo quarto del XX secolo.
Quindi, il Sessantotto, fu la conclusione fragorosa, esplosiva e alla fine disperata di una fase storica che aveva attraversato il Novecento sulla linea dei processi culturali e sociali della “modernità” inaugurata dall’Ottocento e non proprio (come si è talvolta detto e scritto erroneamente) la fase aurorale della postmodernità. In altri termini, fu la conclusione del passato, non la fondazione del futuro. Il suo ruolo di scissura storica consistette nella sua funzione di estremo confine del passato, di spartiacque tra il vecchio e il nuovo che avanzava per suo conto sotto la spinta di inediti progressi dei saperi, della scienza e della tecnologia che sarebbero stati fattori decisivi nel determinare le condizioni oggettive per “cambiare il mondo”.
Infatti, quel che di nuovo il Sessantotto parve generare autonomamente si manifestò prevalentemente in termini di innovazioni nel costume e negli stili della vita privata e della vita pubblica; ma si trattava di innovazioni che in realtà erano il frutto dei primi cambiamenti sociali e antropologici della rivoluzione postmoderna che già stava operando sotto traccia a proteste sociali e a rivendicazioni politiche che si proponevano come attuazioni piene di progetti culturali ed ideologici del passato non realizzati o “traditi” (il marxismo, l’eliminazione dell’imperialismo, l’autentico cristianesimo, la democrazia antifascista promessa dalla Resistenza, ecc.).
Tutto questo risulta ancora più chiaro se si tiene presente l’andamento della trasmissione dei valori e delle idee politiche nella dialettica giovani-anziani, ovvero nella dinamica generazionale del Novecento. È facile notare che in tale dialettica il movimento sessantottino costituisce una particolarità dotata di istanze conformi agli sviluppi sociali del suo tempo, ma non un’eccezione. Infatti, è ben vero che nel suo aspetto originario, e più vistoso, esso fu quel fenomeno che si chiamava contestazione, appunto la contestazione dei figli nei confronti dei padri, di tutti i padri. Tuttavia non si trattava affatto di un fenomeno nuovo. Già la storia italiana aveva conosciuto numerosi fenomeni di contestazione giovanile seppure di segno e di contenuto diverso.
Nel mio libro Le generazioni italiane dall’Unità alla Repubblica ho documentato che già all’indomani della formazione dello Stato unitario, nel 1861, ci furono le prime contestazioni studentesche, dei giovani di varie università, a partire dall’Università di Pavia, nei confronti di genitori, maestri, dei professori e rettori.
Una nuova ondata fragorosa di contestazioni (mentre prima si era registrata una contestazione per così dire “strisciante” e subliminale nella fase di crisi e di superamento dell’età del Risorgimento) si sarebbe sprigionata negli atenei, nel 1908, con caratteri nazionalistici, contro la cosiddetta Italietta giolittiana: un preludio della successiva contestazione giovanile poi ampiamente gestita e strumentalizzata, dopo la prima guerra mondiale, dal fascismo. Perché è vero che, se riletto attraverso un’analisi generazionale, anche il fenomeno fascista delle origini fu – lo ha opportunamente rilevato anche Simona Colarizi nella sua Storia del Novecento italiano3 – un movimento giovanile e giovanilistico, a suo modo un singolare movimento di contestazione dell’establishment.
In tutti i casi del genere è sempre l’utopia che si innalza su una percezione del presente come mediocrità o come insopportabile autoritarismo burocratico dei padri e degli anziani. E l’utopia si autopromuove a progetto politico per cambiare radicalmente la realtà. E si esprime come contestazione del “sistema”. Ma che cosa caratterizza queste contestazioni?
Come esplode l’utopia contro la realtà? E qual è in ogni caso il detonatore dell’esplosione? Per quanto questo possa apparire paradossale, il detonatore consiste proprio nel repertorio dei valori prodotti e codificati dai padri. In altri termini occorre che i padri abbiano già impartito delle lezioniconvincenti per accreditare nei giovani una cultura dei valori da servire e da realizzare fino al dovere civile del sacrificio. Sono loro, gli anziani, i maestri, ad elaborare gli ingredienti ideali che poi le generazioni giovanili emergenti tendono a tradurre in vocazioni e spinte utopiche. Di norma accade che i figli verifichino le insufficienze, le debolezze, le ipocrisie, i tradimenti dei padri e dei maestri. Che li accusino di non essere stati capaci di realizzare quel che essi stessi avevano inculcato, insegnato, enfatizzato. E, nei casi peggiori, che li accusino addirittura di avere tradito i loro stessi ideali. Più o meno la dinamica generazionale è questa. E da questa dinamica nascono i fenomeni delle cosiddette contestazioni giovanili che sprigionano le tensioni antisistema.
Il giovanilismo nazionalista (poi coniugatosi con la retorica populista fascista sul tema della «Vittoria mutilata») era stato animato da una struggente protesta per il patriottismo mal servito o tradito dai padri. Anche il Sessantotto, in fondo, fu l’esplosione di utopie libertarie, anticapitaliste e rivoluzionarie sulla piattaforma di istanze libertarie, anticapitaliste e rivoluzionarie già appartenenti al registro ufficiale delle idealità dei padri. Ancora una volta – l’ho già ricordato – proprio sulla base di quel registro i figli, i sessantottini, se di formazione democratica e antifascista contestavano i padri perché avevano tradito l’antifascismo (la Resistenza) e la democrazia; oppure, se di formazione fascista, perché avevano tradito il fascismo; oppure, se di formazione cattolica, per aver tradito il Vangelo. Non a caso fu una precoce e “scandalosa” sede inaugurale, e un motore della contestazione giovanile del Sessantotto l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Da sinistra a destra, su una line che in definitiva riproduceva la secolare dinamica generazionale che ho sommariamente descritto, il fenomeno del Sessantotto e il successivo «lungo Settantotto» – nonostante l’ovvio conflitto determinato dagli eterogenei e spesso opposti riferimenti culturali, storici ed ideologici dei suoi gruppi litigiosi – ebbe in Italia dei caratteri comuni, tanto idonei ad alimentare scontri immediati e a preparare diverse, simmetriche e quasi sempre drammatiche storie personali dei suoi protagonisti, quanto a mettere in scena, dalle università alle piazze, una sfida collettiva dell’utopia alla realtà.
Ad un certo punto, come si è ricordato, la realtà si impose, inevitabilmente, non eludibile, ben più forte, decisiva e determinante, per il presente e per il futuro, di ogni progetto utopico. E, come si è detto all’inizio, niente sarebbe stato più come prima, non proprio per effetto del Sessantotto, ma per la forza imperiosa e crescente delle trasformazioni epocali che avrebbero prima paralizzato e poi svuotato e annientato la cultura e le tensioni del Sessantotto, infine archiviandole, ora con rimpianto, ora con raccapriccio e riprovazione, nella sempre più caduca memoria di un’ultrasecolare stagione romantica finita per sempre. Le nuove leve giovanili delle generazioni di fine Novecento sarebbero state generazioni consapevolmente (ma più spesso inconsapevolmente) antisessantottine. Non proprio perché dotate di una qualche tendenza a contestare i padri sessantottini sul terreno dei loro ideali accantonati o “traditi”, ma perché figli di un nuovo corso che avrebbe spento tanto nei padri quanto nei figli l’esigenza stessa di possedere e di proporre degli ideali.
Può ben dirsi che il Sessantotto italiano ebbe termine definitivamente come fenomeno riconoscibile (comprese le sue degenerazioni) soltanto nei primi anni Ottanta, spegnendosi infatti in quella fase sociale di cosiddetto «riflusso» (rispetto alle utopiche tensioni rivoluzionarie sessantottine per “cambiare il mondo”) segnata dal ritorno alle suggestioni ben più modeste e realistiche del “privato”, nonché dall’ingresso passivo delle nuove leve giovanili nel circuito maturo di una società ormai egemonizzata dalle sirene del consumismo. Dagli anni Ottanta in poi, sarebbe diventata dominante tra i giovani la tendenza ad una conformistica accettazione dell’esistente (quasi una ventata di consapevole disincanto e di saggio adattamento al “possibile” in alternativa ai padri che avevano provocatoriamente gridato nelle piazze «vogliamo l’impossibile!»), con un adeguamento più o meno consapevole – talvolta dolente, altre volte fiducioso e festoso –, alle ragioni oggettive di un capitalismo vittorioso che sembrava distribuire benessere e premiare le attese di affermazione sociale degli elementi più dinamici e “rampanti”. In un certo senso, il Sessantotto, come meglio vedremo più avanti, si sarebbe convertito in un anti-Sessantotto. E la cosa più vistosa in tutto questo sarebbe stata l’ascesa a numerose posizioni di potere – nella politica e negli establishment dei partiti, nella pubblica amministrazione, nel mondo esclusivo dell’alta cultura ufficiale, delle grandi agenzie della comunicazione e dell’informazione, della pubblicità e dei mass-media, dell’economia e degli affari e, largamente, delle stesse università – di gran parte dei sessantottini che pochi anni prima erano emersi sulla scena pubblica della storia inalberando la bandiera della lotta al cosiddetto “sistema” cioè proprio al sistema capitalistico indicato come la forma più oppressiva e perversa di potere.
Vedendo adesso le cose alla distanza, si potrebbe ben dire che in definitiva il Sessantotto congiurò contro se stesso? Che il suo esito estremo – dopo un lungo itinerario passato attraverso la tragedia del terrorismo (avviata dall’improprio e anomalo revival del 1977) – fu il tradimento delle sue finalità originarie? Che la sua sorte fu quella, assai paradossale, di convertire lo slancio rivoluzionario del suo anno aureo e fatale, appunto il 1968, in una controrivoluzione? Che è tristemente normale che le grandi tensioni utopiche, proprio in quanto e perché utopiche, alla fine si risolvano in una disincantante “normalizzazione”? In altri termini, è corretto dare al Sessantotto, nella sua vicenda tipicamente italiana di «lungo Sessantotto», la registrazione storiografica di un lungo fallimento generazionale?
Se si rispondesse affermativamente a siffatte domande (e ad altre analoghe sempre più correnti, oltre che nella storiografia, nella più vasta pubblicistica sull’argomento) si incorrerebbe di volta in volta in affermazioni dotate di parziale verità, ma nell’insieme errate. Perché è invece un vero storico di cui è stata soprattutto la sociologia a verificare la fondatezza che dopo il Sessantotto l’Italia non sarebbe più stata la stessa di prima. La vecchia Italia di “campagna” delle parrocchie e dei campanili che aveva il suo caposaldo e la sua ecclesìa politica soprattutto nella grande e dominante Democrazia cristiana, così come quella urbana pervenuta da pochi anni (con il cosiddetto «miracolo economico») a mature connotazioni di società industriale e largamente orientata nelle sue tensioni e nei suoi valori dal grande Partito comunista costruito da Togliatti, parve riceverne le stigmate e subirne nel contempo decisive e irreversibili trasformazioni molto simili a quelle in genere prodotte dalle grandi rivoluzioni sociali della storia.
Protagonisti i giovani, quelli della gioventù studiosa delle università e soprattutto, tra loro, i figli dei lavoratori, degli operai e dei contadini, forze emergenti di ceti sociali che per secoli non avevano avuto accesso agli studi superiori e che varcavano adesso quella soglia forzando antiche barriere di classe, tramite i canali approntati dalle stesse istanze modernizzatrici del cosiddetto neocapitalismo, che da una parte erano all’origine delle nuove oppressioni della società urbano-industriale e, dall’altra, avendo bisogno di un’inusitata dotazione di quadri tecnici e professionali, stava incentivando ad ampio raggio la scolarizzazione fino a propiziare il passaggio dalla vecchia università d’élite dominata dai “baroni del sapere” ad un’università di massa nella quale sarebbero stati sempre più protagonisti, in conflitto con i baroni, i professorini incaricati, i ricercatori precari, gli assistenti. Protagonisti, pertanto, quasi “necessari”, proprio gli studenti (fin dalle lotte avviate dalle organizzazioni studentesche nel 1964 e poi negli anni successivi, in anticipo sugli analoghi movimenti in altre parti del mondo dall’America all’Europa, fino all’incentivazione che sarebbe venuta dalla lezione del maggio francese). E protagonisti, insieme agli studenti, i professorini e gli assistenti. E protagoniste, finalmente, e per la prima volta nella storia, le donne, molte donne, che con l’accesso agli studi superiori scoprivano e “reinventavano” il femminismo, sottraendolo ad una tradizione storica che in Italia era stata fondamentalmente elitaria, borghese ed alto-borghese.
Tutto sembrò messo in frenetica discussione. Tutto subì pubblici processi e radicali revisioni. Tutto fu invaso da un’ondata di corrosioni e di delegittimazioni, di critiche travolgenti al presente (quel detestato “sistema”!) e al passato (le ipocrite certezze e sicurezze registrate dai repertori di idee e prescrizioni delle agenzie dominanti del consenso, ovvero dell’oppressivo potere di istituzioni storiche come la Chiesa-Vaticano, di forme organizzative del pubblico come la burocrazia ancora segnata da un’insuperata continuità generazionale e ideologica con quella fascista e come gli stessi partiti dediti a gestire una democrazia dai caratteri filistei che sostanzialmente tradiva nella prassi quotidiana le fonti di una recente legittimazione storica che veniva dall’antifascismo e dalla Resistenza).
Tutto quindi in discussione a sinistra, dove l’attacco al “sistema” prese la strada di un attacco mosso da una sinistra giovanile, che si era formata nel Pci, alla dirigenza dello stesso Pci accusato di stalinismo e di ubbidienza cieca all’Unione Sovietica; un attacco concretizzatosi nella formazione di movimenti “al di là del Pci” e antisovietici che guardavano con ammirazione e con speranza alle suggestioni rivoluzionarie della Cina della Rivoluzione culturale e di Fidel Castro, del castrismo e di Che Guevara.
Ma tutto, o molto, in discussione anche a destra, dove un’altra gioventù a suo modo intenzionalmente “rivoluzionaria” rimproverava al partito neofascista ufficiale (il Movimento sociale italiano di Arturo Michelini e di Augusto De Marsanich) di essersi adattato a un ruolo di supporto alla Democrazia cristiana, un ruolo filoamericano e nella sostanza “antinazionale”, con un ceto dirigente incialtronito dai compromessi e dalla rinunzia ad un autentico fascismo. Ovviamente, Sinistra e Destra, antifascismo e fascismo avrebbero animato gli scontri tra le due gioventù in rotta con le rispettive tradizioni, l’una contro l’altra, nelle università, nelle scuole, infine nelle piazze.
C’erano, quindi, due aree squilibrate di movimenti giovanili, squilibrate perché quelli di sinistra nati alle spalle del Pci e del Psi, e talvolta dentro gli stessi Pci e Psi, erano certamente molto più numerosi e tenevano il campo nelle università, tra Potere operaio, Manifesto, Servire il popolo e Cristiani per il socialismo, maoisti, trotzskisti e guevaristi, poi Lotta continua, ecc. È noto che tra la sinistra e la destra giovanili presto si sarebbero inserite delle oscure forze eversive manipolate dai cosiddetti servizi segreti deviati, forze interessate a destabilizzare l’Italia per ordire nelle sedi senza volto dei poteri occulti (paralleli, e spesso sovrapposti, a quelli ufficiali della Repubblica) le trame di eventuali colpi di Stato, alla maniera dei colonnelli greci, da opporre a una temuta conquista del governo da parte dei comunisti e delle forze anticapitaliste e antiatlantiche: un timore, molto intenso soprattutto nei ceti medi, che aveva le sue fonti immediate nei dati elettorali che evidenziavano una costante avanzata del Pci e nei movimenti di massa che parevano sospingere il paese verso un’imminente rivoluzione.
Ma che questo stesse accadendo i giovani dei movimenti sessantottini non lo sapevano e, ancora, non potevano saperlo. Loro erano piuttosto impegnati nello sforzo di mettere in moto una “rivoluzione culturale”, un cambiamento della mentalità collettiva, una lievitazione dei valori dell’autenticità, della “naturalezza”, della spontaneità del vivere e del testimoniare la vita contro l’autoritarismo, la perfidia, la mediocrità borghese, l’ipocrisia, il bigottismo e il “tradimento” di padri e maestri, di burocrati e di baroni.
Loro, entrando nella nebulosa internazionale di una specie di “globalizzazione della gioventù” sospinta dai campus studenteschi dell’America di Berkeley, di Martin Luther King e di Malcom X all’Europa del maggio parigino, esprimevano nuovi stili e nuovi linguaggi potenziando gli umori recenti della beat generation; esibivano rumorosamente una nuova cultura nutrita dalla Scuola di Francoforte; recitavano collettivamente quella nuova cultura e ne riconoscevano i ritmi incalzanti nella musica scandalosamente dinamica, “eversiva” e insieme gioiosa del rock’n’roll, ne espandevano il senso liberatorio e di inedita umanizzazione nella rivendicazione esibita della libertà sessuale, con i miti politici (il Che, Ho Chi Min, Giap, ma anche Mao Zedong e tanti altri) che si coniugavano con i miti esistenziali (Marilyn Monroe, Bill Haley, Elvis Presley, Joan Baez, Bob Dylan, poi I Beatles e tanti altri, tra i quali, in Italia, soprattutto Luigi Tenco e Francesco Guccini). E, se erano cattolici, la loro fede richiedeva il rinnovamento e l’ardore cristiano del pontificato di papa Giovanni XXIII (contro il politicantismo “medioevale” e clericale del pontificato di Pio XII), insieme alle ariose aperture alla modernità del Concilio Vaticano II, con il corredo del cristianesimo sociale e del cristianesimo anti-imperialistico della teologia della liberazione.
Di quanto di torbido e di strumentale si stava invece svolgendo nelle loro stesse retrovie oltre che, soprattutto, negli spazi oscuri del potere contro il quale si erano mobilitati, si sarebbero accorti di colpo soltanto dopo, il 12 dicembre 1969, con la bomba esplosa a Milano nella sede della Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana: sedici morti innocenti. Ma, così, come è stato ben scritto, anche i sessantottini “perdettero l’innocenza”.
Il «lungo Sessantotto», già all’indomani della strage di piazza Fontana, si sarebbe diviso in due: da una parte il fragoroso movimentismo avrebbe cominciato il suo lento e inesorabile declino verso la rassegnazione e verso un dolente silenzio intriso di pentimento (quasi a riconoscersi responsabile di eccessi degenerati in un’imprevista e incalcolabile violenza); dall’altra, con la speranza di accendere una rivoluzione politica e sociale al di là degli originari propositi di “rivoluzione culturale”, alcuni suoi esponenti sarebbero entrati nei cunicoli e nei circuiti sempre più oscuri e insalubri di un’avventura disperata che pretendeva di imporre l’utopia di un “mondo da rifare” al movimento operaio che invece, per la verità, pur essendo molto combattivo sul terreno delle lotte sindacali per la giustizia sociale e per i diritti democratici, mostrava piuttosto anche in Italia – come del resto aveva già ben rilevato Max Horkheimer – una preminente tendenza al riformismo nell’ambito del “sistema”. Se da una parte il pentimento si sarebbe involuto nelle abiure, dall’altra, l’insistenza sulla strategia della “rivoluzione” avrebbe prodotto nuovi drammatici scontri tra Sinistra e Destra, nuove strumentalizzazioni da parte delle forze interessate a destabilizzare la società italiana e, come sappiamo, la vicenda dei cosiddetti «anni di piombo», con la tragedia del terrorismo.
Proprio nell’area della degenerazione del movimento sessantottino – in una disperata ricerca della “rivoluzione” a sinistra o della cosiddetta “rivolta nazionale” a destra – si sarebbe sviluppato, con una lunga vicenda di sangue, il dramma, quasi al limite tra un esasperato conflitto sociale e una potenziale nuova guerra civile tra italiani, ben descritto nel film di Amedeo Ricucci, dal titolo sintetico ed agghiacciante, Morire di politica.
Esso indica, paradossalmente, anche gli stati d’animo e gli orientamenti di quanti all’opposto, non volendo affatto «morire di politica», se sessantottini avrebbero ripudiato il sessantottismo e se estranei alla cultura e ai movimenti del Sessantotto avrebbero trasformato quella loro originaria estraneità in un convinto ed integrale rifiuto delle ideologie e degli ideologismi, fino a quel morbido disincanto e a quell’opportunistico adeguamento degli anni Ottanta al “mondo così com’è” al quale ho già accennato.
È quest’ultimo l’orientamento che sembra essersi potenziato negli anni e che oggi ritengo di potere rilevare come assai diffuso e radicato nella generazione del XXI secolo. Si tratta di un orientamento, o meglio, di un processo di depoliticizzazione (e quindi anche, in nuce, di destoricizzazione) che, come ho spiegato in alcuni miei precedenti libri, non si deve tanto al fatto che il lungo Sessantotto italiano sia andato in crisi scindendosi tra l’area dell’abiura e l’area dell’avventura disperata; ma si deve soprattutto a un fenomeno epocale e mondiale che negli anni Settanta ha cominciato a cambiare radicalmente le carte sul tavolo della storia: una rivoluzione dagli effetti non minori della prima rivoluzione industriale (una nuova rivoluzione postindustriale cominciata appunto negli anni Settanta), che era già nel sottofondo del Sessantotto senza che i sessantottini riuscissero ancora a coglierne la sconvolgente intensità “strutturale”; in breve, la rivoluzione che amo definire elettronico-informatica, quella che è all’origine della fenomenologia sociale ed antropologica del cosiddetto “postmoderno” e dei radicali processi di cambiamento attualmente giunti a maturazione nel nuovo secolo al di là delle forme e dei valori della vecchia società industriale nata nell’Ottocento. Sta di fatto che il crollo delle ideologie e degli ideologismi e la destoricizzazione della cultura (la cultura del Sessantotto era stata, invece, una cultura che, per e dentro le ideologie, rappresentava il culmine utopico della valorizzazione romantica della storia, fino a promuovere la stessa utopia al rango di storicità assoluta!) sono processi che marciano insieme, indissociabili. E sta di fatto che nessuno dei giovani di oggi sarebbe benché minimamente disposto a «morire di politica» e neppure, certamente, a «morire di storia».
D’altra parte, chi come me, essendo uno storico, in virtù del suo ufficio civile, ha l’onere di tutelare la memoria critica degli eventi, adesso, ripensando al Sessantotto aureo e fragoroso dell’anno 1968 e al «lungo Sessantotto» degenerato negli anni della violenza e del terrore, non ha certo il compito di “processarli” per addivenire a un qualsiasi giudizio di assoluzione o di condanna. Semmai, ha il compito di suggerirne un’interpretazione il più possibile convincente tentando di cogliere, di quei complessi eventi, sia i loro rapporti di continuità con il passato, sia i fattori di cambiamento e di rottura con il passato che, sempre da quei complessi eventi, si sono proiettati sulle vicende storiche di fine secolo fino a raggiungere il nostro presente. Il che mi sembra di avere già fatto, almeno parzialmente, con la prima parte delle mie riflessioni.
Ma adesso, affrontando una seconda parte, la parte conclusiva, mi sembra persino doveroso proporre un’interpretazione della vicenda del Sessantotto che risulti, per quanto purtroppo più generale e generica, più unitaria e “stringente”. Si tratta, in breve, di inquadrare il complessivo movimento sessantottino nella dialettica giovani-anziani della storia del Novecento.
Per farlo, necessariamente con molto schematismo, mi è utile ritornare al titolo del film appena citato. Quel titolo, Morire di politica, è una frase un po’ ambigua perché potrebbe contenere una valutazione politica positiva della politica, suggerendo che è emozionante e civile immolarsi per una causa politica (e, pertanto, esaltando la politica stessa come valore) oppure, di contro, potrebbe avere una significazione particolarmente negativa: come dire “si muore a causa della politica”, perché la politica (con il suo portato di ideologismi) costituisce un’esperienza pericolosa, fino agli estremi di un vero e proprio pericolo mortale.
In realtà, le vicende del Sessantotto (soprattutto quelle del «lungo Sessantotto», per quanto siano state disperate e spesso violente) mi sembrano più funzionali ad un’altra lettura della frase, una lettura insieme più semplice e dalle valenze esistenziali pienamente conformi agli ideali della generazione sessantottina sia di sinistra che di destra: si può morire di politica se e quando la politica è enfasi dell’impegno per testimoniare una passione che si nutre nel pensiero come una passione civile (un vivere non per sé, ma per gli altri); così, come è possibile morire di amore, si può morire di ideali, quali che siano questi ideali, sempre che siano soggettivamente avvertiti come ideali degni di una dedizione completa ed assoluta. Altra cosa è verificare se si tratta di ideali oggettivamente davvero degni di meritare il sacrificio della vita e, al limite, se valga la pena sacrificarsi per gli ideali, quali che siano. Ma questo non è deciso e verificato dai sentimenti degli individui; è, invece, deciso e verificato dal corso concreto della storia. E i sessantottini, tutti (a parte gli immancabili opportunisti di ogni tempo), a qualsiasi parte politica appartenessero, ciascuno ritenendo già scontata in partenza a suo favore la verifica storica come accade di norma ai giovani, non coltivavano dubbi circa il valore degli ideali che li sospingevano alla lotta e, se necessario, al sacrificio. La loro visione “eroica” e sacrificale dell’impegno politico potrebbe rappresentarsi come l’espressione estrema di una tradizione romantica della gioventù riprodottasi nella storia del Novecento nel passaggio da una generazione ad un’altra. Non a caso, si sarebbe poi esaurita e spenta, come ho già rilevato, con l’affermazione del “postmoderno” e con i crescenti sviluppi della rivoluzione elettronico informatica nell’ultimo quarto del XX secolo.
Quindi, il Sessantotto, fu la conclusione fragorosa, esplosiva e alla fine disperata di una fase storica che aveva attraversato il Novecento sulla linea dei processi culturali e sociali della “modernità” inaugurata dall’Ottocento e non proprio (come si è talvolta detto e scritto erroneamente) la fase aurorale della postmodernità. In altri termini, fu la conclusione del passato, non la fondazione del futuro. Il suo ruolo di scissura storica consistette nella sua funzione di estremo confine del passato, di spartiacque tra il vecchio e il nuovo che avanzava per suo conto sotto la spinta di inediti progressi dei saperi, della scienza e della tecnologia che sarebbero stati fattori decisivi nel determinare le condizioni oggettive per “cambiare il mondo”.
Infatti, quel che di nuovo il Sessantotto parve generare autonomamente si manifestò prevalentemente in termini di innovazioni nel costume e negli stili della vita privata e della vita pubblica; ma si trattava di innovazioni che in realtà erano il frutto dei primi cambiamenti sociali e antropologici della rivoluzione postmoderna che già stava operando sotto traccia a proteste sociali e a rivendicazioni politiche che si proponevano come attuazioni piene di progetti culturali ed ideologici del passato non realizzati o “traditi” (il marxismo, l’eliminazione dell’imperialismo, l’autentico cristianesimo, la democrazia antifascista promessa dalla Resistenza, ecc.).
Tutto questo risulta ancora più chiaro se si tiene presente l’andamento della trasmissione dei valori e delle idee politiche nella dialettica giovani-anziani, ovvero nella dinamica generazionale del Novecento. È facile notare che in tale dialettica il movimento sessantottino costituisce una particolarità dotata di istanze conformi agli sviluppi sociali del suo tempo, ma non un’eccezione. Infatti, è ben vero che nel suo aspetto originario, e più vistoso, esso fu quel fenomeno che si chiamava contestazione, appunto la contestazione dei figli nei confronti dei padri, di tutti i padri. Tuttavia non si trattava affatto di un fenomeno nuovo. Già la storia italiana aveva conosciuto numerosi fenomeni di contestazione giovanile seppure di segno e di contenuto diverso.
Nel mio libro Le generazioni italiane dall’Unità alla Repubblica ho documentato che già all’indomani della formazione dello Stato unitario, nel 1861, ci furono le prime contestazioni studentesche, dei giovani di varie università, a partire dall’Università di Pavia, nei confronti di genitori, maestri, dei professori e rettori.
Una nuova ondata fragorosa di contestazioni (mentre prima si era registrata una contestazione per così dire “strisciante” e subliminale nella fase di crisi e di superamento dell’età del Risorgimento) si sarebbe sprigionata negli atenei, nel 1908, con caratteri nazionalistici, contro la cosiddetta Italietta giolittiana: un preludio della successiva contestazione giovanile poi ampiamente gestita e strumentalizzata, dopo la prima guerra mondiale, dal fascismo. Perché è vero che, se riletto attraverso un’analisi generazionale, anche il fenomeno fascista delle origini fu – lo ha opportunamente rilevato anche Simona Colarizi nella sua Storia del Novecento italiano3 – un movimento giovanile e giovanilistico, a suo modo un singolare movimento di contestazione dell’establishment.
In tutti i casi del genere è sempre l’utopia che si innalza su una percezione del presente come mediocrità o come insopportabile autoritarismo burocratico dei padri e degli anziani. E l’utopia si autopromuove a progetto politico per cambiare radicalmente la realtà. E si esprime come contestazione del “sistema”. Ma che cosa caratterizza queste contestazioni?
Come esplode l’utopia contro la realtà? E qual è in ogni caso il detonatore dell’esplosione? Per quanto questo possa apparire paradossale, il detonatore consiste proprio nel repertorio dei valori prodotti e codificati dai padri. In altri termini occorre che i padri abbiano già impartito delle lezioniconvincenti per accreditare nei giovani una cultura dei valori da servire e da realizzare fino al dovere civile del sacrificio. Sono loro, gli anziani, i maestri, ad elaborare gli ingredienti ideali che poi le generazioni giovanili emergenti tendono a tradurre in vocazioni e spinte utopiche. Di norma accade che i figli verifichino le insufficienze, le debolezze, le ipocrisie, i tradimenti dei padri e dei maestri. Che li accusino di non essere stati capaci di realizzare quel che essi stessi avevano inculcato, insegnato, enfatizzato. E, nei casi peggiori, che li accusino addirittura di avere tradito i loro stessi ideali. Più o meno la dinamica generazionale è questa. E da questa dinamica nascono i fenomeni delle cosiddette contestazioni giovanili che sprigionano le tensioni antisistema.
Il giovanilismo nazionalista (poi coniugatosi con la retorica populista fascista sul tema della «Vittoria mutilata») era stato animato da una struggente protesta per il patriottismo mal servito o tradito dai padri. Anche il Sessantotto, in fondo, fu l’esplosione di utopie libertarie, anticapitaliste e rivoluzionarie sulla piattaforma di istanze libertarie, anticapitaliste e rivoluzionarie già appartenenti al registro ufficiale delle idealità dei padri. Ancora una volta – l’ho già ricordato – proprio sulla base di quel registro i figli, i sessantottini, se di formazione democratica e antifascista contestavano i padri perché avevano tradito l’antifascismo (la Resistenza) e la democrazia; oppure, se di formazione fascista, perché avevano tradito il fascismo; oppure, se di formazione cattolica, per aver tradito il Vangelo. Non a caso fu una precoce e “scandalosa” sede inaugurale, e un motore della contestazione giovanile del Sessantotto l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Da sinistra a destra, su una line che in definitiva riproduceva la secolare dinamica generazionale che ho sommariamente descritto, il fenomeno del Sessantotto e il successivo «lungo Settantotto» – nonostante l’ovvio conflitto determinato dagli eterogenei e spesso opposti riferimenti culturali, storici ed ideologici dei suoi gruppi litigiosi – ebbe in Italia dei caratteri comuni, tanto idonei ad alimentare scontri immediati e a preparare diverse, simmetriche e quasi sempre drammatiche storie personali dei suoi protagonisti, quanto a mettere in scena, dalle università alle piazze, una sfida collettiva dell’utopia alla realtà.
Ad un certo punto, come si è ricordato, la realtà si impose, inevitabilmente, non eludibile, ben più forte, decisiva e determinante, per il presente e per il futuro, di ogni progetto utopico. E, come si è detto all’inizio, niente sarebbe stato più come prima, non proprio per effetto del Sessantotto, ma per la forza imperiosa e crescente delle trasformazioni epocali che avrebbero prima paralizzato e poi svuotato e annientato la cultura e le tensioni del Sessantotto, infine archiviandole, ora con rimpianto, ora con raccapriccio e riprovazione, nella sempre più caduca memoria di un’ultrasecolare stagione romantica finita per sempre. Le nuove leve giovanili delle generazioni di fine Novecento sarebbero state generazioni consapevolmente (ma più spesso inconsapevolmente) antisessantottine. Non proprio perché dotate di una qualche tendenza a contestare i padri sessantottini sul terreno dei loro ideali accantonati o “traditi”, ma perché figli di un nuovo corso che avrebbe spento tanto nei padri quanto nei figli l’esigenza stessa di possedere e di proporre degli ideali.
Giuseppe Carlo Marino
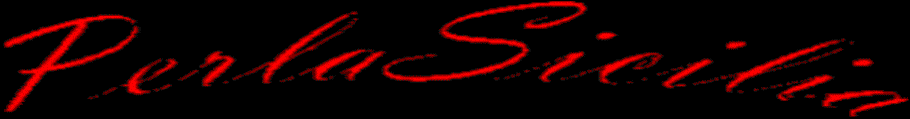
Nessun commento:
Posta un commento