La storia, secondo me, è una disciplina complessa perché tenta di prefigurarsi il vero o l'attendibile tra le situazioni e le vicende che il tempo, nel suo trascorrere, offre alla nostra attenzione e di raccontarlo minuziosamente. Tutto ciò assieme al tentativo di comprendere il senso di ciò che accade e di ciò che siamo.
Prima di ogni altra considerazione è necessario fare un breve ma indispensabile riferimento al tempo in cui la Sicilia si pose nei fatti come interlocutrice di primo piano a livello europeo.
E’ opportuno ricordare che durante i due secoli di dominazione mussulmana, la Sicilia era tornata ad essere centro economico, politico e culturale, di rilievo, nel Mediterraneo e non lo era stata più dal tempo felicissimo della colonizzazione greca.
La dominazione bizantina dell’Alto Medioevo, pur non esaltandola, aveva tuttavia salvato la Sicilia dall’imbarbarimento in cui era precipitata tanta parte d’Europa e le aveva restituito, specialmente ad Oriente, una cultura greca allineandola al culto ed al rito dell’Ortodossia di Costantinopoli. Inoltre, l’imperatore d’Oriente Costante II dal 663 al 668, per motivi strategici, fece di Siracusa la capitale del suo impero.
Ma fu solo con i Normanni che la Sicilia rientrò in Europa, non come lontana provincia, ma come Regno autonomo che si confrontava con le più eminenti realtà politiche, economiche e culturali di quel tempo e che dimostrava di poter saldare al proprio interno culture d’Oriente e d’Occidente così diverse tra loro.
Soprattutto con Ruggero II il “Regnum” di Sicilia, e Palermo in particolare, risplendettero da ogni punto di vista e tesero ad illuminarsi quasi al pari di Bisanzio. In ogni caso La Sicilia divenne centro di uno scacchiere che comprendeva sia tutta l’area mediterranea che quella europea.
A Palermo si confrontavano la cultura greco - bizantina, la cultura mussulmana (araba e berbera), quella ebraica e quella latina che veniva reintrodotta dopo duri scontri con i papi, proprio ad opera dei sovrani Normanni.
Palermo divenne poi la capitale del grande impero del colto ed eccentrico Federico II ma, purtroppo, dopo la caduta degli Svevi iniziò un declino più o meno lento ma quasi sempre costante ed inesorabile. Infatti i “Vespri siciliani”, tanto esaltati nel periodo risorgimentale soprattutto grazie a Michele Amari (ma anche a Giuseppe Verdi), segnavano invece soltanto un delicato momento di passaggio. Infatti presto si sarebbero create le premesse per un inesorabile e profondo allontanamento del ruolo culturale, economico, politico e sociale della Sicilia rispetto al cammino del resto dell’Europa, penisola italiana compresa. Con l’avvento del XIV secolo l’unica entità economica siciliana strutturale e condizionante era e sarebbe rimasta ancora, per circa quattro secoli, il feudo. L’unico riferimento politico vincente: l’oligarchia baronale. L’unico ambiente (o quasi) da cui provenisse una qualche elaborazione culturale: quello ecclesiastico.
Una fortissima, variegata ma costante dialettica sul piano politico vide, dalla conquista normanna e dalla nascita del feudalesimo in Sicilia, sino al periodo risorgimentale, due protagonisti politico - istituzionali contrapposti. Da un lato il potere centrale, da chiunque fosse rappresentato, e dall’altro quello dei baroni.
Mentre in altre parti della penisola italiana fiorivano i Comuni e poi le Signorie e nel resto d’Europa sbocciava il ceto medio, in Sicilia non solo non si trasformava ma addirittura si rafforzava il feudo. Altrove fiorivano arti, mestieri, commerci. Altrove si diffondeva il credito, la piccola proprietà, si ridimensionava, anche pesantemente, l’antico sistema feudale, in agricoltura si differenziavano le colture e se ne introducevano di nuove. In Sicilia continuava a consolidarsi il feudo che si concentrava soprattutto su un tipo di produzione fondamentale, quella che si era affermata sin dai tempi dall’impero romano e cioè la coltivazione del grano su base latifondista.
I cereali e i prodotti ortofrutticoli, pur ingenti, talvolta però non bastarono neanche per soddisfare il fabbisogno isolano.
Un antico e feroce disboscamento aveva già profondamente modificato le condizioni idrogeologiche e produttive dell’Isola e la situazione peggiorò nella prima parte del 1800.
L’estrazione dei minerali di cui la Sicilia disponeva veniva attuata in modo rozzo e primitivo e i conseguenti rapporti di produzione furono decisamente leonini e la condizione dei minatori subumana.
Ciò valse soprattutto per l’estrazione dello zolfo che non veniva nemmeno lavorato ma esportato allo stato grezzo.
Inoltre occorre tenere sempre presente un dato fondamentale e cioè la tensione dialettica tra il potere centrale e le baronie feudali che in ogni modo e con ogni mezzo si opposero, in ogni tempo, a qualsiasi tentativo di autentico cambiamento della struttura feudale latifondista. Questa situazione si protrasse, sostanzialmente inalterata, sino al XX secolo.
La mancanza della nascita di un vero ceto medio borghese, in senso europeo, condizionò negativamente, sin dalla fine del Medioevo, la crescita complessiva dell’Isola.
Deputata alla produzione in termini, oggi diremmo, macroeconomici fu la campagna e gli affittuari dei feudi, i cosiddetti “gabelloti”, divennero strumento di controllo e di gestione della produzione al posto di un’aristocrazia che sempre più si allontanava dalle proprie responsabilità sociali e, in concreto, dalla stessa realtà produttiva del latifondo. I “gabelloti”, rappresentarono una entità socio – rurale intermedia tra i baroni e coloro che concretamente lavoravano la terra. Si posero sempre come alter ego del padrone ma il loro ruolo non fu quasi mai assimilabile, nei fatti, a quello di una potenziale ed efficiente borghesia agraria. In realtà il gabelloto siciliano voleva solo sostituirsi al barone, detenere e gestire il suo potere e scimmiottare il suo stile di vita.
Inoltre le corporazioni artigiane cittadine furono quasi esclusivamente subordinate alle commesse dell’aristocrazia e del clero e spesso divennero il loro braccio armato.
La rete viaria era molto primitiva, incredibilmente lacunosa e scadente. E, nei momenti migliori, solo una ventina di malconce navi, garantì i rapporti con l’Italia e il resto del Mediterraneo. Per lunghi periodi i collegamenti da Palermo con la stessa Napoli, sede del sovrano, avvennero solo due o tre volte in un anno con un paio di imbarcazioni. Spesso i viaggiatori stranieri si stupirono di vedere i porti siciliani vuoti o quasi vuoti!
Il XVIII secolo però entrava in Sicilia con possibilità di cambiamenti importanti. Un’inattesa ventata europea giunse nel 1713 con Vittorio Amedeo di Savoia e durò solo cinque anni, fortemente contrastata dall’aristocrazia e dalla popolazione che non avevano maturato alcuna esigenza di cambiamento. Come sempre si era trattato di un avvicendamento di potere voluto da potenze e volontà esterne di cui la Sicilia non poteva che essere mera realtà oggettuale. I tentativi di introdurre in Sicilia criteri amministrativi efficienti, come quelli piemontesi, il progetto di razionalizzazione delle finanze e della vita pubblica nel suo complesso, furono nobilissimi ma vani. Tanto che Vittorio Amedeo, viste le negative e corali reazioni dei sudditi, esaminata l’immane arretratezza del contesto e avendo dovuto affrontare anche un imprevisto scontro con la chiesa, decise di fare a meno della Sicilia e si adoperò in tal senso a livello internazionale. La situazione complessiva favorì, alla fine, questa sua esigenza e, in seguito ad un duro conflitto austro – spagnolo, la Sicilia passò agli Asburgo per 14 anni, sostanzialmente restaurativi, durante i quali, tuttavia, si tentò qualche cambiamento sul piano commerciale come, ad esempio, l’apertura ai mercati nord – africani anche per cercare di neutralizzarne la potente pirateria che devastava le coste isolane.
L’Europa intanto cambiava velocemente. Lo stesso impero asburgico sotto l’imperatrice Maria Teresa e con l’impegno del cancelliere Kaunitz, provvedeva a ridimensionare notevolmente il sistema feudale, ad attuare il censimento, a ripartire le imposte con criteri di equità, a riorganizzare la struttura amministrativa e quella giudiziaria dell’impero, a sopprimere, assieme all’inquisizione, la censura ecclesiastica e il diritto di asilo in chiesa. Inoltre vennero promosse sia l’agricoltura che l’industria, si incrementò l’istruzione, si aprirono biblioteche e si potenziavano le università (come quella di Pavia). Si costruirono teatri si favorirono le arti. Le riforme proseguirono e si incrementarono con il suo successore l’imperatore Giuseppe II.
Ancora più radicali furono le riforme nel Granducato di Toscana con Leopoldo II che, per primo in Europa, abolì la pena di morte, rese tutti i cittadini uguali di fronte al fisco, favorì uno sviluppo industriale moderno e abolì le corporazioni, entrò in conflitto col papato avallando le tesi gianseniste della superiorità dell’autorità conciliare rispetto a quella papale e così via.
Nella stessa Napoli Carlo III di Borbone, con il suo ministro Bernardo Tanucci, iniziava un vasto e significativo programma di riforme che continuarono con il successore di Carlo, Ferdinando sino a quando il Tanucci no fu sostituito per opera dell’intrigante e anglofila moglie del re, Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d’Austria e sorella di Maria Antonietta regina di Francia.
In quel periodo, per la Sicilia, una significativa possibilità di cambiamento e di riallineamento ad una dimensione europea, si ebbe con Domenico Caracciolo marchese di Villamarina, viceré dal 1781 sino al 1786. Illuminista di vasta cultura, formatosi attraverso esperienze diplomatiche in Italia e in Europa, ma soprattutto a Parigi, ed esperto di economia, fu ritenuto particolarmente idoneo da re Ferdinando per tentare di trasformare e migliorare le arretratissime condizioni economiche e sociali della Sicilia. I sovrani napoletani, generalmente, evitavano pure di visitare l’isola, tuttavia ben sapevano quanto fosse potente la voglia di autonomia dell’aristocrazia siciliana ma erano anche consapevoli dell’arretratezza complessiva di quello che oggi chiameremmo il “sistema Sicilia”. Il nuovo viceré, pertanto, dovette sostenere lo scontro atavico tra volontà del potere centrale e realtà baronale dominante.
Caracciolo si era formato anche e soprattutto a Parigi, centro di un cambiamento culturale epocale, attraverso contatti con i maggiori intellettuali francesi di quel tempo tra i quali Diderot, Turgot ed Helvetius e comprese perfettamente l’importanza di quella forte compagine sociale che in Europa si andava sempre più affermando.
Ecco cosa scriveva il Caracciolo nel 1774: “Per esperienza ho trovato in tutti i paesi dove sono stato, sempre il ceto medio, la classe di mezzo della società, essere la più capace, più costumata, più virtuosa”. Quando giunse in Sicilia non poté fare a meno di constatare sia la quasi inesistenza di un ceto medio, sia il fortissimo contrasto tra pochi ricchissimi e una quantità sterminata di poveri.
Egli individuò con chiarezza le cause sociologiche dell’arretratezza della Sicilia e scrisse: ”Viddi subito che la depressione, miseria e schiavitù del Popolo era la vera unica sola ragione della decadenza di questo Regno”.
Nel tentativo di cominciare ad esercitare effettivamente il potere conferitogli, Caracciolo esordì con una circolare che imponeva ai funzionari e ai magistrati di rivolgersi per ogni questione al Vicerè e non direttamente al Re o a un suo ministro, come erano abituati a fare. Decise, inoltre, di liberalizzare il commercio del grano sottraendolo all’arbitrio padronale e cercò comunque di ridimensionare il potere dei feudatari accentuando le prerogative del potere centrale contro quello del Parlamento dei nobili. Per colpirne l’albagia, tra gli altri provvedimenti, limitò da 340 a 17 il numero delle cerimonie ufficiali cui era tenuto a partecipare il Senato di Palermo. E avendo deciso di restituire immagine e pulizia alla sporchissima Palermo (secondo la stessa testimonianza del Goethe), decise di fare lastricare alcune strade e decretò una tassa sulle 784 carrozze circolanti a Palermo per sostenerne la spesa. Ma i nobili si ribellarono a questo provvedimento considerandolo un sopruso e non pagarono neanche questa tassa anche se Caracciolo, con un’azione dimostrativa, fece sequestrare la carrozza di una nobildonna e la fece vendere all’incanto sulla pubblica piazza. Si comprende anche da episodi apparentemente marginali, come questo, quale fosse il potente muro oppositivo che intralciò in ogni modo i tentativi riformatori del Vicerè e il perché delle continue richieste al sovrano napoletano di sostituire il Caracciolo.
Ma un risultato straordinariamente significativo egli lo consegui. Il 27 marzo del 1782 (e cioè solo sei mesi dopo il suo arrivo) dispose l’abolizione dell’Inquisizione che, avendo in passato, torturato ed ucciso atrocemente, con grande ostentazione di potere e perverso apparato di spettacolo, migliaia di malcapitati, manteneva detenute, ormai, solo tre vecchie donne accusate di stregoneria. L’ultimo rogo a Palermo risaliva al 1732.
Tuttavia, l’Inquisizione in quanto tale rappresentava da un lato l’immagine di un mondo che ormai la maggioranza delle coscienze, a livello europeo, ripudiava e condannava e dall’altro un’occasione di ulteriore arricchimento per i feudatari a causa delle cospicue rendite di cui godevano i grandi dignitari dell’Inquisizione che, ovviamente, appartenevano soprattutto al ceto aristocratico.
Poco dopo doveva seguire lo scontro politico – istituzionale più significativo. La Sicilia, sin dal tempo dei Normanni si era dotata di un Parlamento di cui va ancora fiera poiché era addirittura il primo d’Europa. Esso aveva allora le seguenti caratteristiche: era diviso in tre bracci, quello demaniale, quello baronale o militare e quello ecclesiastico. E’ evidente che in realtà esso fosse per l’intero nelle mani dell’aristocrazia di cui fu sempre strumento di potere e di tutela. I baroni, nel corso degli anni lo resero sempre più funzionale alle loro pretese. Come in Inghilterra, nessuna tassa poteva venire imposta al paese a meno che non fosse stata votata, come “donativo” dal Parlamento. Di regola, l’aristocrazia siciliana scaricava sulle classi subalterne anche il peso di questi cosiddetti donativi.
Caracciolo tentò di riformare e limitare il potere del Parlamento baronale riconducendo, per quanto possibile, il potere decisionale al sovrano e propose di riconsiderare giuridicamente, con attenzione, le antiche leggi: “Volentes “ e “Si aliquem”, risalenti al XIII secolo, in cui si configuravano gli obblighi feudali nei confronti del re. Solo nel 1788, quando Caracciolo non era più Vicerè ma lo era il suo degno successore il Principe di Caramanico, re Ferdinando ratificò la bontà delle tesi del Caracciolo promulgando una specifica “prammatica sanzione”. Ciò comportava in termini concreti: l’obbligo da parte dei feudatari di fornire servizi alla corona, il divieto di trasmissione testamentaria o, comunque, di alienazione dei feudi che dovevano tornare alla corona qualora non si fosse dimostrato di possedere un titolo adeguato ad acquisirli.
Inoltre egli tolse ai baroni l’elezione dei giurati e dei sindaci nelle loro terre, ordinò la chiusura delle prigioni sotterranee nei castelli, tolse ai feudatari la facoltà di ordinare ai vassalli di seminare i territori signorili prima di quelli di loro spettanza, vietò l’alienazione a gabella del misto e mero imperio, cioè della potestà giurisdizionale civile e penale, avocò al tribunale statale i rendiconti di tutte le comunità, anche di quelle baronali, ampliò le franchigie del porto di Messina, città in cui esisteva una certa borghesia e che egli preferì sempre alla pletorica e corrotta Palermo.
Favorì, inoltre, gli scambi, l’ordine pubblico e la sicurezza dei trasporti commerciali marittimi.
Palermo era ancora priva di una sua università. Sin dal Medioevo la penisola italiana si era via via costellata di centri universitari. Persino in Sardegna sorsero nel 1764 l’università di Cagliari e cinque anni dopo quella di Sassari per volontà di Carlo Emanuele III di Savoia. Il viceré Caracciolo nel 1782, dopo l’abolizione dell’Inquisizione, utilizzando le somme precedentemente confiscate ai gesuiti, istituì a Palermo un’Accademia presso una chiesa sconsacrata. Primo passo verso l’università che nascerà nel 1805.
La sua frenetica opera legislativa si era ispirata a principi di modernità, ma le sue leggi si infrangevano contro la resistenza e l’ostilità di coloro che avevano interesse a non farle eseguire.
Persino le classi più umili a favore delle quali tendeva la sua politica lo detestarono anche per provvedimenti moralizzatori di modesta portata, ma comunque per loro incomprensibili e inaccettabili, come la riduzione dei festeggiamenti in onore di santa Rosalia da cinque a tre giorni e la costruzione di un nuovo cimitero pubblico per evitare di continuare a seppellire i cadaveri nelle chiese da cui esalavano fetori nauseabondi. Provvedimento, questo, che provocò anche la reazione della chiesa che vedeva limitati i propri introiti.
E tuttavia questo viceré aveva tutti i requisiti culturali e intellettuali per restituire la Sicilia all’Europa. Tra i suoi progetti vi erano anche quelli di costruire nuovi acquedotti, di avviare la costruzione di una vera rete viaria in una Sicilia senza strade e di collegare queste nuove vie coi maggiori porti dell’isola. Per più di un secolo, i riformatori successivi avrebbero fatto riferimento alla sua opera come al più valido punto di partenza, ma egli, nello stesso palazzo vicereale, fu sempre un isolato sia per la feroce e diffusa opposizione contro ogni suo tentativo di civile riforma sia a causa del suo temperamento rigoroso e schivo.
Il successore di Caracciolo, fu un altro illuminista: il Principe di Caramanico, gran Maestro della Massoneria del Regno di Napoli. Anche Caracciolo era massone e, in tutta l’Europa di quel tempo, moltissimi intellettuali illuminati lo erano, aristocratici o borghesi o professionisti o artigiani che fossero.
Pur essendo meno creativo del Caracciolo, tuttavia il Caramanico ebbe un maggior senso della diplomazia e maggior tatto e duttilità nell’affrontare l’occhiuto baronato isolano. Si servì ampiamente dei migliori intellettuali siciliani del tempo come Francesco Paolo Di Blasi, come Paolo Balsamo o come il De Cosmi, a cui affidò anche un incarico straordinariamente importante e innovativo per l’arretratissima Sicilia, e cioè quello di fornire una istruzione di base ai figli del popolo istituendo scuole aperte a chiunque. Prima di allora l’istruzione era stata gestita dai gesuiti, sino alla loro cacciata ai tempi del Tanucci, ma era altamente selettiva ed inadeguata. Quasi il 100% della popolazione rurale era, in Sicilia, analfabeta e, nelle città, la situazione, a livello popolare, migliorava di poco.
Il Caramanico, inoltre, riuscì ad attuare anche quel progetto del Caracciolo che prevedeva l’istituzione del catasto con cui poter avere contezza soprattutto della reale ricchezza dei feudatari, e poi riuscì a far promulgare da re Ferdinando, come si è già detto, quella importantissima prammatica sanzione del 1788 tesa a ridimensionare considerevolmente il potere baronale.
L’anno successivo il Caramanico emise un altro provvedimento di primaria importanza abolendo la servitù della gleba ed i contadini così passarono, da quella servile, alla condizione di salariati occasionali. Il viceré si adoperò, inoltre, per una distribuzione delle terre demaniali al fine di favorire la piccola proprietà.
Dal punto di vista culturale si diffuse, oltre al pensiero illuminista anche e specificamente, una cultura empirista i cui riferimenti essenziali furono soprattutto Locke e Hume ma anche alcuni degli enciclopedisti francesi. Oltre al citato De Cosmi vi aderirono anche Benedetto D’Agata, Rosario Gregorio e Domenico Scinà. Purtroppo, tuttavia, una reale e diffusa crescita della società siciliana, entro tempi politici, si dimostrava impossibile.
Oltre a quasi tutti i tentativi del Caracciolo anche molti dei provvedimenti del Caramanico restarono lettera morta e il successivo vicerè l’arcivescovo Lopez, reagì duramente al pericolo francese. Infatti le armate repubblicane rivoluzionarie erano giunte allo stretto di Messina. La paura di profondi cambiamenti si andava diffondendo per l’intera Europa e, in Sicilia, il Lopez remò decisamente contro le riforme e si adoperò a favore delle vecchie ma pur salde baronie, scegliendo una politica reazionaria. Molti intellettuali siciliani considerati giacobini, fuggirono in Francia mentre, in Sicilia, Francesco Paolo di Blasi ed altri venivano torturati e giustiziati.
Nel 1798 l’esercito napoleonico entrò a Napoli e il re Ferdinando fuggì sulla nave ammiraglia della flotta inglese comandata dal Nelson, alla volta di Palermo e il clima di restaurazione divenne sempre più forte. Velocemente la Sicilia si andava trasformando in una sorta di protettorato britannico.
Ma la storia è ricca di sorprese. La Sicilia si avvicinava e si allontanava dall’Europa secondo le fibrillazioni di un secolo di grandi trasformazioni. Ciò che da un lato, in Sicilia, sembrava inserirsi nel corso della storia, ammesso che ne abbia uno ben definito, dall’altro sembrava opporvisi e viceversa.
Le maggiori forze europee che si scontravano con Napoleone, avevano sviluppato al loro interno una classe borghese piuttosto attiva ed avevano dovuto avviare una serie di riforme più o meno significative pur mantenendo caratteristiche politiche dominanti dichiaratamente conservatrici. Ed ecco che la successiva occupazione inglese della Sicilia che vide Lord Bentinck governatore dell’isola, condusse alla Costituzione siciliana del 1812 che trasformava i beni feudali dei baroni in beni allodali assicurando loro, così, la proprietà dei feudi, superando il sistema feudale e ridimensionando l’autorità del re a favore del Parlamento che veniva riformato sul modello bicamerale inglese. Si costituì una Camera dei Pari (totalmente aristocratica) ed una Camera dei Comuni che in Inghilterra era costituita dalla nascente borghesia ma invece in Sicilia era composta da aristocratici o da loro rappresentanti. Era cambiata la cornice ma, senza che gli inglesi comprendessero sino in fondo la realtà siciliana, il contenuto era sempre lo stesso. Alla fine però pure gli inglesi compresero e affermarono che per far valere in Sicilia la costituzione concordata con l’aristocrazia locale, sarebbe stata necessaria una presenza militarmente forte e un potere centrale capace di farla rispettare effettivamente. Il successore del Bentinck, A’Court, sosteneva: “Se decideremo di appoggiare la Costituzione, appoggeremo una cosa pochissimo adatta al paese… I siciliani si aspettano che gli altri facciano tutto per loro… Essi sono stati sempre abituati all’obbedienza passiva”.
La successiva restaurazione fu netta. Nel 1816, Ferdinando III di Sicilia e IV di Napoli diede al regno un nuovo statuto. Divenne Ferdinando I dell’unitario “Regno delle Due Sicilie”. La Costituzione siciliana del 1812 veniva così, di fatto, superata dal nuovo assetto istituzionale. Anche gli inglesi erano stati giocati.
Fu abolito il regno autonomo di Sicilia e la sua bandiera. Ma la monarchia non mostrava più un volto illuminato. Ci si allineava rapidamente alle disposizioni del Congresso di Vienna.
Si aboliva anche la libertà di stampa e si rafforzavano le forze e le misure di polizia.
Ma la legge fisica del compenso secondo cui ad ogni azione ne corrisponde un’altra uguale e contraria pare che in qualche modo sia riscontrabile anche nelle vicende delle società umane lungo il corso del loro divenire e, comunque sia, intorno agli anni venti del XIX secolo nacquero nei vari stati italiani le cosiddette società segrete ed in particolare la “Carboneria” e la mazziniana “Giovane Italia”. Anche la Massoneria che aveva rappresentato linfa vitale per il secolo dei lumi, sostenne vigorosamente questi processi dinamici di una cultura che si andava modificando.
L’idealismo romantico conduceva verso ipotesi sociali e istituzionali che andavano dalle originarie posizioni liberali a quelle democratiche sino a quelle del nascente socialismo. Le idee illuministe erano state assorbite e trasformate. Era decisamente superato anche l’assolutismo illuminato che aveva trionfato nel secolo precedente e ogni popolo tendeva a costituirsi in nazione indipendente, a disporre di una propria Costituzione e quindi ad autodeterminarsi. Nasceva ciò a cui la storia avrebbe poi attribuito il nome di Risorgimento.
Ed è sull’onda di queste trasformazioni che arriviamo prima alla rivoluzione del 1820 e poi a quella del 1848.
La rivoluzione del 1820 non vide come protagonisti i carbonari siciliani che consistevano in una sparuta schiera clandestina di appartenenti al ceto medio intellettuale e che tendevano ad uno stato unitario costituzionale. Come al solito la rivolta fu contro gli odiati napoletani ed ebbe risvolti pesantemente contraddittori. Da un lato si sventolava il tricolore e dall’altro il vessillo giallo dell’autonomia. Palermo, che dirigeva la rivolta con in testa il principe di Villafranca, e la città di Girgenti si schierarono con l’aristocrazia antinapoletana e, da sempre, contraria a qualunque autorità centrale ma favorevole all’autonomia più ampia possibile. Messina, Catania, Siracusa Caltanissetta e, ad occidente, Trapani ritennero invece che era maggiormente conveniente schierarsi con i Borboni.
Si fece ricorso anche a banditi e a prigionieri per implementare le forze combattenti. In realtà, tranne una davvero esigua schiera di intellettuali, a nessuno, in Sicilia, interessava in quel momento uno stato nazionale o soltanto vagheggiare un allineamento con le tendenze più avanzate che potevano profilarsi nel resto d’Europa come reazione al congresso di Vienna. Fu un’occasione perduta che si concluse con la sconfitta e con la mortificazione di Palermo.
Un’altra occasione perduta furono i moti del 1837 che videro maggiormente impegnata la Sicilia orientale, in seguito al reale diffuso convincimento che fosse stato il governo, attraverso polveri avvelenate, a causare la pesante epidemia di colera. Anche in questa occasione si chiesero a gran voce autonomia e costituzione ma giunse invece una feroce repressione.
Quella successiva, del 12 gennaio del 1848 fu invece una rivoluzione più articolata e complessa e più vicina ai valori risorgimentali. Le idee mazziniane e garibaldine avevano fatto breccia anche in Sicilia ma scrive il Romeo: “Molti degli insorti, persino quelli che portavano bandiere tricolori, potevano avere, nella migliore delle ipotesi, solo una nozione indistinta di cosa fosse l’Italia o una costituzione…”.
La spinta rivoluzionaria venne, come sempre, dalle disastrose condizioni economiche e sociali sia delle città che, soprattutto, delle campagne. Diversamente da quella del 1820, questa rivoluzione ebbe un sostanzioso coinvolgimento territoriale in tutta l’isola. Anche stavolta si fece ricorso a bande armate, come i Di Miceli di Monreale e gli Scordato di Bagheria, che da secoli controllavano quei territori e che poco o nulla masticavano di unità nazionale e costituzione. Si organizzarono squadre armate che si divisero il territorio e spesso si abbandonarono a massacri, saccheggi, taglieggiamenti e sequestri di persona. A seguito di ciò i nobili decisero di istituire, come era stato fatto nel 1820, una Guardia Nazionale, costituita soprattutto da membri delle corporazioni di arti e mestieri, che limitasse il potere delle squadre, mantenesse l’ordine e tutelasse la proprietà.
Tuttavia, una volta cacciate le truppe borboniche, sventolò il tricolore e il volto a tre gambe dell’antica Trinacria sostituì i gigli borbonici. Si inviarono anche un centinaio di uomini a dare un contributo simbolico alla liberazione della Lombardia dagli austriaci, si vagheggiò della Sicilia come parte di una ipotetica federazione nazionale di stati italiani. Per quanto riguarda l’unità nazionale vera e propria erano ancora troppo pochi coloro che comprendevano cosa significasse e che la rivendicavano con piena consapevolezza.
Tra i tentativi seri di cambiamento, per altro molto avversati dai nobili, si distinsero quelli di Filippo Cordova che puntavano alla nazionalizzazione di alcuni latifondi e al loro frazionamento. Ancora una volta si chiedeva libertà da Napoli, ma con uno sguardo più concreto verso una ipotesi unitaria che riguardasse l’Italia intera. Si chiedeva, comunque una costituzione moderna, sulla falsariga di quella concessa in Francia da Luigi Filippo nel 1830.
A Napoli invece si verificarono sommosse e manifestazioni autenticamente carbonare che riuscirono a costringere il sovrano a concedere davvero la costituzione. Era la prima di tante altre costituzioni che stavano per essere concesse. Seguirono infatti quelle emesse da Carlo Alberto di Savoia, da Leopoldo II di Toscana e da Pio IX, il cosiddetto “papa liberale”.
Alla rivoluzione siciliana però i Borboni reagirono militarmente inviando un potente esercito che trovò resistenza a Messina.
Si ipotizzarono utopistiche e disperate soluzioni politiche ma, a Palermo, come scrisse il Crispi: “i moderati temevano più la vittoria del popolo che quella delle truppe borboniche”.
Ci si avviava così verso un periodo di restaurazione e di gretta chiusura da parte dei sovrani napoletani che culminerà con la fine del regno borbonico sotto Francesco II a seguito della conquista garibaldina.
L’11 Maggio del 1860 Garibaldi sbarcava a Marsala e l’anno successivo nasceva il Regno d’Italia e cioè, per la prima volta nella storia, uno stato italiano nel senso moderno di questo termine.
La nostre brevi riflessioni si avviano verso la conclusione.
Aldilà di una visione del tutto pessimista possiamo dire che nel periodo che abbiamo considerato si è assistito ad una crescita progressiva, sofferta, lenta (ma, purtroppo, mai cospicua) di una certa borghesia e del ceto medio intellettuale che era all’inizio costituito soprattutto da ecclesiastici come De Cosmi, Balsamo, Scinà, Gregorio e poi invece da laici come Ferrara, Perez, Michele ed Emerico Amari, D’Ondes e tanti altri. Bisogna riconoscere, senza alcun dubbio, che per quanto riguarda l’aspetto artistico, il lusso dei palazzi e delle ville nobiliari, la bellezza delle chiese e degli oratori, l’aristocrazia e il clero di Sicilia, dimostrarono di essere abbastanza in linea con il resto dell’Europa. I modelli culturali inglese e francese furono metabolizzati ma, come si è visto, solo da una parte esigua della popolazione cittadina e così pure le idee risorgimentali. Le masse, soprattutto nelle campagne siciliane, a ridosso dell’unità d’Italia, vivevano ancora in uno stato di quasi assoluto analfabetismo. Sul piano economico e sociale dobbiamo riconoscere che, almeno formalmente, il feudalesimo era stato abolito sin dal 1812, ma il latifondo d’impianto feudale era più vigoroso che mai malgrado tutti i tentativi volti a ridimensionarlo.
Sul piano politico era ormai innegabile che lo stato unitario, annettendo la Sicilia, l’aveva di fatto traghettata in un contesto che viveva e si confrontava con la altre nazioni del Continente. Un rientro in Europa più per effetto di un trascinamento politico – istituzionale (oggi diremmo: geopolitico) che per altro.
Le peculiarità socio – culturali di allora ci sono state descritte in maniera eccellente nel romanzo di Tomasi di Lampedusa: “Il Gattopardo” a cui è sempre bene fare riferimento per una validissima comprensione del contesto.
A questo punto potrebbe restare, a qualcuno, la curiosità di sapere come sia andata poi a finire. Bastano poche parole. La condizione socio – economica della Sicilia non era destinata affatto a migliorare negli anni successivi ma semmai sarebbe stata coinvolta in pieno nella nascente “questione meridionale”. Gli stessi “Fasci siciliani” (1891-1893), fenomeno più articolato e non solo rurale, sarebbero nati pure per questioni ancora legate all’atavica struttura feudale del territorio ed è davvero significativo leggere nella famosa “Storia della Sicilia medievale e moderna” di Denis Mack Smith che: ”la minaccia più seria ai latifondisti fu la legge Micheli…del 1922, perché confermò il diritto dello Stato di espropriare una qualsiasi parte incolta di una grande proprietà…” ma aggiunge, il Mack Smith, che il Micheli “…fu in seguito assalito brutalmente da assassini fascisti e il voto che il Parlamento aveva espresso sulla riforma agraria fu semplicemente ignorato”. Nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale ci avrebbero pensato mafia e poteri reazionari, più o meno occulti, a fermare nel sangue l’occupazione delle terre da parte dei contadini siciliani. La mondializzazione dell’economia che, proprio allora iniziava, avrebbe, però, fatto estinguere nel giro di un cinquantennio, un fenomeno che per tanti secoli e da tanti punti di vista, aveva condizionato e mortificato lo sviluppo economico della Sicilia, rallentandone e limitandone pesantemente anche la crescita culturale e civile e, pertanto, l’integrazione nella dimensione europea. Ancor oggi, di certo, non possiamo dire che questa realtà, malgrado notevoli sforzi e sacrifici, anche eroici, della parte più sana dei siciliani, si sia affrancata culturalmente e socialmente dalle tante e gravissime devianze e limitazioni che da quell’eredità derivano.
Vincenzo Guzzo
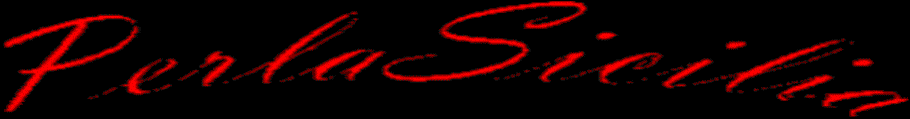
Nessun commento:
Posta un commento